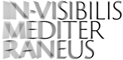NEI LUOGHI DEL SUD, MEMORIA E SGUARDO SONO IN RELAZIONE RECIPROCA, L’UNA RICORDA E L’ALTRO RIVELA. L’INVISIBILE DIVENTA SENTIMENTO ED EMOZIONE, NON PER SCOPRIRE, MA PER IMMAGINARE. IL PAESE DI PENTEDATTILO SECONDO SALVATORE GRECO
La storia del paese di Pentedattilo – pentedattilo significa cinque dita e il nome descrive il profilo delle rocce del monte Calvario sulla costa ionica della Calabria – finisce con il terremoto del 1783. O meglio il terremoto è l’inizio di un’agonia che terminerà con l’abbandono dei luoghi, inesorabile e inarrestabile, fino a lasciare, negli anni Sessanta del Novecento, un paese fantasma.
Pentedattilo ha una storia antichissima, risale al 640 prima di Cristo, costruito dai Calcidesi e poi divenuto fortezza per controllare la fiumara di Sant’Elia, importante perchè era la via di passaggio verso l’Aspromonte.
Alla fine del dominio romano la via di passaggio non era più così essenziale all’equilibrio geo-politico. Il borgo passò di proprietà in proprietà fino a quando venne acquistato dalla famiglia dei marchesi Alberti nel 1686.
Tra i marchesi Alberti e gli Abenavoli, ex feudatari del borgo, un’accesa inimicizia condusse a una sanguinosa storia di delitti e carneficine, con il pretestuoso motivo di una rivalità amorosa.
È da qui nasce la cupa leggenda che predice che l’enorme mano di roccia delle cinque dita si abbatterà sugli uomini per punirli della loro sete di sangue. E poi nel 1783 il terremoto, il decadimento, il degrado. La fine.
La fine?
Pentedattilo è ancora un luogo suggestivo e ammaliante, per quello che la storia tramanda, ma soprattutto per l’invisibile, scomparso o celato.
Ne ha restituito il fascino Maurits Cornelis Escher, appassionato di Italia e di Mediterraneo, portando Pentedattilo nelle mostre itineranti in tutto il mondo.

Salvatore Greco ne traccia, con linguaggio visivo, pennellate di luoghi in forma di scrittura, in alcuni punti lieve come un acquarello, in altri duro come un’incisione e in altri ancora forte come un olio. Disvela non solo le parti celate, ma anche quelle che non esistono più e che non possono tornare se non in una visione in cui la memoria e l’immaginazione si mescolano ai colori e agli odori, all’asprezza del vento e al dolore per la perdita dell’identità.

IL PERIPLO DELLA ROCCA E LA PASTORA di Salvatore Greco
È passato poco tempo o tanti anni? Non lo so più, forse colpa di qualche pandemia.
Finalmente potevo scardinare quella cornice, ed entrare in quell’immagine metafisica, che a mo’ di reliquia capeggiava solenne nel salotto buono di casa e che mio padre ostentava orgoglioso agli ospiti forestieri. Solo in età matura avevo capito che si trattava della riproduzione di un’incisione di Maurits Cornelis Escher, ne fui compiaciuto, e non era quella né una visione fantastica né allucinata.
Finalmente sarei andato oltre l’icona, l’immagine bidimensionale, quella che conoscevo dalle lunghe letture e dalle logore pagine del web a bassa risoluzione, che negli anni avevo consultato per ritagliarmi il mio personale pezzo di calabresità, spero non in versione pittoresca.
Ebbi qualche attimo d’esitazione di fronte a quella scena, un istante dopo tirai fuori la mia vecchia macchina reflex dalla custodia e cominciai a scattare fotografie a ripetizione, su e giù caoticamente, per le rughe deserte e tra le rovine delle case aggrappate.
Pergole, porte spalancate, tramezzi di canne, intonaci sfogliati, sulle mura dalle tempere forti ormai sbiadite e stanche, scritte e disegni quasi primitivi, tetti consumati, edicole sacre, cisterne per l’acqua e piccoli giardini pensili, ma non ero un turista asiatico in visita celere in Italia, il tempo non mi mancava. Mi accolse il panoramico e panciuto muretto in calce della piccola piazzetta, adiacente alla chiesa, accesi la prima sigaretta, riposi la macchina fotografica e sedetti a riflettere. Due sedie rosse con tavolinetto in un incantevole spazio pubblico senza arredo urbano!!

Un impianto senza cardo o decumano semplicemente funzionale ai livelli degradanti dell’orografia del sito.
Entrai nella chiesa che per molti anni era stata abbandonata.
Lo scritto inciso su una lastra commemorativa, sormontata dallo stemma araldico degli Alberti, signori della rocca, documentava, dopo il rito greco, che il primo prelato ad officiare in lingua latina in questa chiesa era stato nel 1655 il Bovese, Don Domenico Toscano.
Dalla chiesa protopapale greca a quella arcipretale latina, un passaggio storico da commemorare? O un segnale di inarrestabile perdita di coscienza della propria identità!
Quel fortilizio naturale sembrava precipitarmi addosso e i buchi solcati dal tempo nella rossiccia parete arenaria, profondi occhi che mi fissavano, cambiando spesso espressione!
Quanta modestia in quel coagulo di viuzze, le case, una diversa dall’altra e tutto insieme in sintonia con il paesaggio. Abitazioni lacerate, avevano posseduto cose semplici, abitanti intenti al focolare, all’orto, al porco e alla chiesa, un minimalismo fatto di bisogni e non sollievo per un’inconscia eutanasia, rappresentazione mascherata da tendenza contemporanea, dove molte case stilizzate, senza odore di soffritto, sono abitate solo da zelanti collaboratrici domestiche.
I vecchi dimoranti si erano improvvisati mastri muratori, architetti e forse qualcosa di più!
Si erano fatte le dieci del mattino e il sole già faceva sentire i suoi benefici, avevo un appuntamento! Decisi allora per fare più in fretta di percorrere un altro sentiero, più breve e scoprire così il lato B di quell’isola di pietra tra la precoce dischiusa primavera. Mi incamminai lungo un viottolo solitario, lo sguardo pendolava continuamente tra lo sfondo a mare fino a incontrare la Sicilia, la costa messinese e ancora oltre, il vulcano di Schizzo, l’Etna sempre più vicino che con la sua cima innevata contrastava con quel primo piano di terra bruciata ricoperta a macchie di fichi d’india, agavi e finocchietto selvatico, la rupe sempre più incombente.
A un certo punto lasciai il percorso, mi aprì la via, alla ricerca di strani incontri, tra spighe che andavano dorandosi e i cardi pungenti e colorati, non si fecero attendere!
Un vecchio canto popolare calabrese intonava:
Iu fici vutu di fari ‘ncastellu,
cridendu ch’era iu lu castellanu.
Doppu chi lu fici artu e puru bellu,
la pinna mi pigghiaru di la manu.
Restai comu lu pitturi senza pennellu
comu lu notaru senza pinna a manu.
Una piccola abitazione abbandonata, col tetto piano calpestabile, un mandorlo a proiettarle ombra sul muro assolato, profondamente diversa da tutte quelle già incontrate con il classico tetto di coppi. Un volume moderno, una “white box” logorata dal tempo, immersa in un alto tappeto di colori spontanei, riflessi nel fascino silenzioso e primitivo di questo luogo, la presenza maestosa della rupe di sfondo, un altrove da tutto. Semplicemente simile a molte architetture tradizionali mediterranee, liberate dalla schiavitù della pianta in funzione del tetto.
Questo mi confortava e mi confermava ancora una volta la potenza del vicino e lontano, grande piccolo paesaggio, in grado di risolvere qualunque querelle stilistica.
Ripresi a camminare estasiato, mi persi senza paura, pensieri impalpabili all’ombra della roccia e scorsi da lontano una piccola edicola sacra, il sentiero lasciato doveva essere lì vicino.

Quasi senza accorgermene magicamente mi ritrovai nel luogo dell’appuntamento.
Rossella, la pastora, l’ultima abitante, l’etrusca custode della terra dei greci di Calabria era lì a aspettarmi, indaffarata nelle sue faccende. Poche parole, semplici, profonde e in dieci minuti mi raccontò la sua vita!
Ragazza, aveva lasciato la sua Viterbo per venire a vivere in questo paradiso di Calabria. Sacrifici e turbamenti le si leggevano nel volto sempre sorridente, sapienza strappata a questa terra ed emanava un intenso profumo di pane mentre mi parlava delle sue capre e dei suoi progetti. Più tardi ci ritrovammo seduti a tavola, pietanze semplici svelarono antichi rituali e andammo indietro nel tempo fino al ceppo greco. Mangiare a sazietà probabilmente per sfatare i tanti periodi contraddistinti da bisogni e stenti, attraversati nonostante tutto con fervente e decorosa dignità.

Un arrugginito cartello turistico narrava la già nota e sanguinosa vicenda accaduta la notte di Pasqua del 1686, Alberti e Abenavoli, Montecchi e Capuleti. Intorno a quegli anni, il primo abbandono, i contadini si spinsero verso la marina.
Impegnato nell’ascesa alla rocca ero io a creare quel paesaggio e chi sa quanti prima di me lo avevano fatto. Marcovaldo, sua moglie Domitilla con i quattro figli Michelino, Teresa, Pietruccio e Filippetto, mi aveva preceduto alla ricerca di aria buona.
Formaggio primosale e workaway, chiacchierammo per un tempo che mi sembrò non finire mai, prima di lasciarla con la promessa di nuovi incontri, mi diede indicazioni precisissime di paesaggio!
Avevo fatto il periplo del monolite!! Ancora in quel coagulo di viuzze, sedetti a riposare, il tempo di una meritata sigaretta e l’impulso mi portò subito dopo all’ascesa della rupe, circa duecento metri fino alla cima inaccessibile, passando quasi dentro il campanile maiolicato della chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
L’ultimo rudere della rocca portava incastonata sul portale una maschera apotropaica, pronta a scacciare gli spiriti cattivi, le anime maligne.
La conquista della rupe rappresentava un atto fondativo, di senso sia fisico che simbolico – trascendentale e avevo in mente quella magnifica testimonianza immortalata dal Petrarca nella famosa lettera del “Monte Ventoso”, uno dei pochi insegnamenti che mi era entrato indelebilmente nel cuore e nella mente. Orgoglio nostrano la conquista del Ventoso, anche quella del Pirata Nazionale, Marco il campionissimo coccolato e abbandonato.
Finalmente la vetta, tra i resti dell’ultimo castello, tutto sembrò essere annunciato e dal podio posto in alto, lo sguardo si perdeva fino alla marina, facendomi leggere le parti di quella fulgida composizione.
Una dimora del vento sfuggita ai cammini di Paolo Rumiz. Ero davanti all’ennesimo monocromo Guernica? Ma qui non c’era stata guerra civile! Catastrofiche alluvioni, terremoti e l’incuria dell’uomo avevano dipinto l’ennesimo arazzo. Tutti questi paralleli mi imponevano di guardare ad occhi aperti oltre il già detto e il visibile.

Mi arrampicai ancora più in alto e con un po’ di sforzo raggiunsi una stretta gola e la fatica fu ampiamente ripagata dalla vista, ero padrone incontrastato sui diruti tetti dell’abitato, il cimitero su l’altura vicina, l’imitazione del paese era lì a due passi.
Era quello un paesaggio compensativo, consolatorio, o un pensiero critico rispetto alla mia vita urbana?
In quella stessa scena vista da vicino, avevo toccato con mano l’altra faccia della medaglia: la fragilità ambientale, l’atavica cultura dell’emergenza, l’esatto “sfasciume pendulo” così ben sintetizzato da Giustino Fortunato.

Un’incontrollata azione antropica moderna aveva prodotto per fortuna in zone circoscritte, più danni di tutti quei già detti catastrofici eventi naturali. Terra ballerina, punto di convergenza di ben tre placche continentali, storicamente aveva condannato questa umanità. A completare l’opera, deriva sociale e urbana, anime nere, profanazione, forti contraddizioni, memoria senza spessore, deserto dei tartari!
Di ruderi di pietra e monumenti, l’Italia non n’è avara, ma qui lo sfondo non è contorno, palcoscenico conservato, il cielo, gli odori del vento, i colori dell’esuberante vegetazione delle specie endemiche erano un’esplosione di colori e di profumi.
Guarivano l’anima, le diverse specie di piante grasse, esemplari unici la Centaurea e le Allium pentadactyli.
Il vallone delle orchidee, che pur avevo già attraversato distrattamente, vignetta senza parole!
La fiumara di Annà e quella di S. Elia, circoscrivevano la rocca in un abbraccio erosivo, disegnando coni prospettici che dalla marina si perdevano fino alle pendici dell’Aspromonte.
Avevo finalmente l’opportunità di praticare il silenzio, un assordante silenzio, la solitudine, senza essere costretto a obliterare nessun biglietto.
La solitudine si dice sia prerogativa esclusiva dei sovrani. Cento, mille sovrani abitavano quel paesaggio, io non ero stato solo, occhi verdi invisibili mi avevano accompagnato!!!
Paragonare questo silenzio verticale e rumoroso, con l’altro subdolo e invisibile dei giorni festivi in città, mi metteva ansia, si era fatto obbligo, poesia e dramma.
Non riuscivo più a fotografare.
Cominciarono davanti a quell’impressione a martellare, le vecchie discussioni universitarie del gruppo Ibrido e gli insegnamenti di Franco, il maestro capitolino dai capelli bianchi, mentore silente e tuonante nel descrivere il carattere calabrese!
“Un’intelligenza lucida che convive con un sentimento coraggioso ma anarchico, fortemente individuale, velato di pessimismo e di malinconia…. Tutto il paesaggio calabrese ha un grande respiro, anche quando fallisce”.
Ora, i compagni di viaggio di Mediterranei Invisibili erano più vicini di quanto potessi pensare! Ebbi perfino l’impressione di vedere Ernesto correre nel sentiero poco più a valle, Mario, Stefano e Massimiliano impegnati in avanscoperta con i treppiedi sulle spalle, mentre gli altri e il capitano seduti a discutere all’ombra di una pergola panoramica.
Intanto il sole cominciava a tramontarmi alle spalle, cosa per me inusuale, e il buio trascendeva nella mia immaginazione, impedendomi di augurare a questa terra di divenire scenografia di un grande palcoscenico per un’industria panoramica e turistica, dove i veri valori e significati potessero venire alterati e banalizzati.
Economia di mercato; attrarre investitori, nuovi ricchi, magari dall’estero, l’obiettivo prioritario; ma non eravamo forse noi i primi investitori? E i progetti condivisi?
Lontani i tempi in cui Totò e Peppino vendevano la fontana di Trevi all’ignaro sig.Caciocavallo.
Quanti bei retini colorati, accomunati da uno scadente “copia e incolla” per una svendita immobiliare di ammuffite metropoli di cartone.
Nella dendrocronologia urbana, dentro gli ultimi anelli periferici da rammendare, tanti avevano già letto il grigio presagio di una modernità non finita, annunciata nelle urbane nature morte e metafisiche di Sironi Mario, futurista!
La notte del 16 aprile 1686, importante sicuramente per questa scena, ma anche questa notte in arrivo lo era, insieme a tutti i frantumi di un’auspicata ri-generazione antropologica, tanto fisica che spirituale.
I festival, le associazioni, linfa vitale per un corpo sofferente, vero è che in questa terra tutto è raccontato come lento “come alle estremità di un organismo” scriveva Saverio Strati, ma a volte questo può essere un valore. C’è da dare fiato al singolo con un’attinente logica contestuale, in un riverbero corale, dall’arcaico al post-moderno, un “effetto farfalla”, liberandosi da vecchi sistemi che avevano creato nocivi “parassiti di paesaggio”.
Non mi fu difficile immaginare da lassù il borgo del tempo passato, memorie trapiantate i racconti dell’etrusca pastora. Zoccoli di cavalli, notabili panciuti, creature scalze, carri rumorosi, eco di voci lontane, suoni di ceramelle, tintinni di campanacci, muri di ricotta, uomini e bestie nello stesso catoio, vociare di ambulanti, parroco trino, maestro e dottore, giorni senza lustru, fumi di pane, eremi, fuochi propiziatori, processioni di santi, riti di fondazione, cultura taciuta, fiumare terapeutiche e distruttrici, tutto scorreva velocemente come i titoli di coda di un film appena visto.
Erano passate diverse ore e attendevo immobile il lento tramonto sugli aspri monti, di spalle e in controluce, affacciato verso la costa, a un tratto pensai di essere il “Viandante”, manifesto della pittura più romantica.
Vaneggiavo?
I limiti della nebbia umana erano ora a confronto con la grandiosità della natura.
Senza pausa di fiato, sentimenti soggettivi facevano a pugni con sensazioni oggettive.
Cercavo spiegazioni, o era semplicemente l’ebbrezza della solitudine?
Perdonate, scusate le tante citazioni lungo questo impervio cammino, credetemi ne sfoggio, né vanità, ma stampelle, ancore sicure, per un lungo e faticoso itinerario morale autodidattico, che mi stavano insegnando come inserire la freccia di sorpasso e dire di no, prima di tutto a me stesso.
Prima di rientrare, mi accorsi di non essere stato solo, una piccola lucertola era stata gran parte del tempo immobile a farmi compagnia in una sorta di estasi contemplativa, la salutai e gli diedi appuntamento alla prossima volta.
Servizio fotografico di Salvatore Greco